Seconda parte
Un ciclo di incontri da gennaio a maggio
Il ciclo “Anatomia della Seconda guerra mondiale - Volti e storie” proposto per l’anno 2024-2025 prosegue da gennaio a maggio in collaborazione con il centro Europe Direct di Modena e Anppia di Modena aggiungendo elementi importanti alle riflessioni condotte grazie a Massimo Turchi, Chiara Colombini, Toni Rovatti e Alessandro Santagata. Il percorso uscirà ora dal contesto strettamente locale e nazionale per assumere un’ottica di più ampio respiro, che abbraccia temi di rilevanza internazionale e riflessioni che interessano alcune costanti della storia ma su cui occorre continuare a interrogarci.
Molti aspetti del conflitto sono stati accantonati, alcune aree geografiche sono state trascurate, così come diverse categorie sociali e attori che hanno giocato ruoli importanti, seppur non evidenti, trovando luce e collocazione solo in tempi più recenti.
La seconda parte della rassegna ha quindi due obiettivi principali: da un lato indagare aspetti specifici del periodo bellico e del sistema discriminatorio e concentrazionario che hanno investito diversi stati, dall’altro guardare a fenomeni che hanno trovato la loro quintessenza durante la guerra attraverso un punto focale più ampio, così da inquadrarli nelle giuste coordinate e darne spiegazioni più complete. Seguendo questa direzione, giungeremo a una riflessione più vicina al presente, che ci aiuterà a riannodare i fili della storia, e a comprendere quali dinamiche di pace e di guerra hanno caratterizzato gli ultimi decenni.
"Una volta avevo una grande famiglia"
Discriminazioni e persecuzioni di sinti e rom
Incontro con Chiara Nencioni, autrice di A forza di essere vento. La persecuzione di rom e sinti nell'Italia fascista (Edizioni ETS 2024)
lunedì 20 gennaio, ore 18
Galleria Europa, Piazza Grande 17, Modena
L'autrice dialoga con Luca Bravi, Università di Firenze
Incontro in collaborazione con Fondazione Fossoli
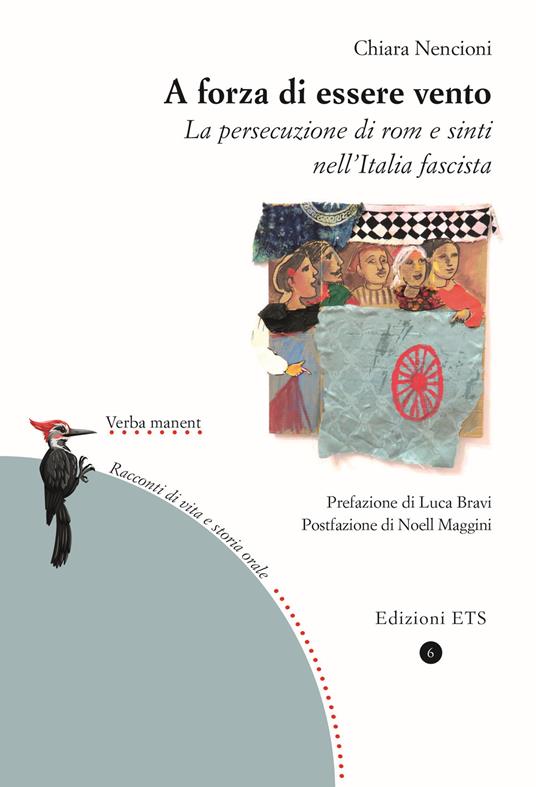 «Ci mandavano a morire, ci mettevano su questi vagoni senza mangiare, senza bere, e questi rom andavano allegri, chi prendeva la fisarmonica, chi il violino, chi la chitarra e cantavano. Dicevano “Ci mandano a lavorare”, invece dove li mandavano? Auschwitz!». Cosa sappiamo del Porrajmos (o Samudaripen), la persecuzione di sinti e rom perpetrata anche nel nostro Paese? Molto poco, troppo poco. Mandati a morire nei lager del Terzo Reich dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, uccisi in Croazia dai collaborazionisti Ustaša o espulsi dal confine orientale in Italia, rinchiusi in campi di concentramento lungo tutta la penisola, questa era la sorte degli “zingari”. A forza di essere vento – scrive Luca Bravi nella prefazione – «ha il merito indiscusso di aver dato in stampa le parole che testimoni diretti della persecuzione fascista, sinti e rom, avevano affidato a interviste e ad un’oralità che rischiava d’andar perduta. Ne scaturisce una voce di comunità, come di frequente succede quando si tratta di queste popolazioni, che chiede essenzialmente di essere ascoltata». Si tratta di una storia “dal basso” che ripercorre i tanti rivoli di una vicenda negletta, la cui ricostruzione non è soltanto un indispensabile esercizio di memoria, ma serve a riflettere sul presente di un popolo ancora oggi guardato con sospetto e pregiudizi.
«Ci mandavano a morire, ci mettevano su questi vagoni senza mangiare, senza bere, e questi rom andavano allegri, chi prendeva la fisarmonica, chi il violino, chi la chitarra e cantavano. Dicevano “Ci mandano a lavorare”, invece dove li mandavano? Auschwitz!». Cosa sappiamo del Porrajmos (o Samudaripen), la persecuzione di sinti e rom perpetrata anche nel nostro Paese? Molto poco, troppo poco. Mandati a morire nei lager del Terzo Reich dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, uccisi in Croazia dai collaborazionisti Ustaša o espulsi dal confine orientale in Italia, rinchiusi in campi di concentramento lungo tutta la penisola, questa era la sorte degli “zingari”. A forza di essere vento – scrive Luca Bravi nella prefazione – «ha il merito indiscusso di aver dato in stampa le parole che testimoni diretti della persecuzione fascista, sinti e rom, avevano affidato a interviste e ad un’oralità che rischiava d’andar perduta. Ne scaturisce una voce di comunità, come di frequente succede quando si tratta di queste popolazioni, che chiede essenzialmente di essere ascoltata». Si tratta di una storia “dal basso” che ripercorre i tanti rivoli di una vicenda negletta, la cui ricostruzione non è soltanto un indispensabile esercizio di memoria, ma serve a riflettere sul presente di un popolo ancora oggi guardato con sospetto e pregiudizi.
Chiara Nencioni, docente di lettere nelle scuole superiori, collabora con le università di Pisa, Firenze e con la rete degli Istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea. Ha pubblicato articoli e saggi sulla Shoah, sul Porrajmos, sul confine orientale e sul genocidio di Srebrenica.
Violenze sotto il sole africano
Fare i conti con la dominazione coloniale italiana
Incontro con Valeria Deplano, coautrice di Storia del colonialismo italiano. Politica, cultura e memoria dall’età liberale ai giorni nostri (Carocci 2024)
mercoledì 19 febbraio, ore 18
sala Giacomo Ulivi, viale Ciro Menotti 137, Modena
L'autrice dialoga con Giulia Dodi, Istituto storico di Modena
in collaborazione con Moxa Modena per gli altri
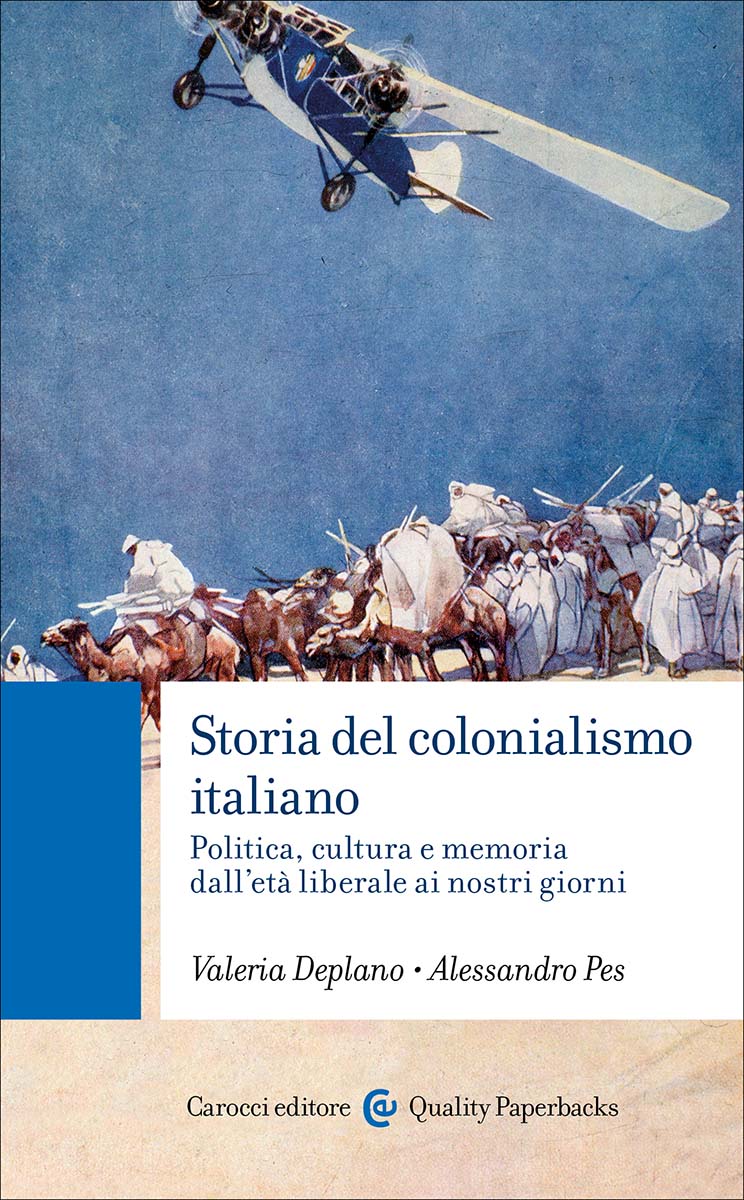 Il colonialismo si è intrecciato con la storia d’Italia dall’Ottocento alla Seconda guerra mondiale e ha proiettato la sua ombra anche nel periodo repubblicano, fino ai giorni nostri. Muovendo dal più recente dibattito storiografico, il volume ricostruisce per la prima volta in maniera sistematica e sintetica la storia dell’espansionismo italiano in Africa in età liberale e durante il ventennio fascista e ripercorre le vicende delle sue eredità e implicazioni nell’Italia del secondo Novecento e del XXI secolo. Si raccontano non solo i progetti politici, le relazioni diplomatiche, le operazioni militari, le violenze dell’occupazione, le leggi razziste, ma anche i movimenti di persone da e per l’Africa e il modo con cui la scuola, i libri, i film, la scienza e i monumenti hanno reso possibile l’espansione, contribuendo a costruire immaginari che influenzano ancora oggi le vite di milioni di donne e di uomini.
Il colonialismo si è intrecciato con la storia d’Italia dall’Ottocento alla Seconda guerra mondiale e ha proiettato la sua ombra anche nel periodo repubblicano, fino ai giorni nostri. Muovendo dal più recente dibattito storiografico, il volume ricostruisce per la prima volta in maniera sistematica e sintetica la storia dell’espansionismo italiano in Africa in età liberale e durante il ventennio fascista e ripercorre le vicende delle sue eredità e implicazioni nell’Italia del secondo Novecento e del XXI secolo. Si raccontano non solo i progetti politici, le relazioni diplomatiche, le operazioni militari, le violenze dell’occupazione, le leggi razziste, ma anche i movimenti di persone da e per l’Africa e il modo con cui la scuola, i libri, i film, la scienza e i monumenti hanno reso possibile l’espansione, contribuendo a costruire immaginari che influenzano ancora oggi le vite di milioni di donne e di uomini.
Valeria Deplano è professoressa associata di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Cagliari. Tra le sue recenti pubblicazioni citiamo: la curatela di Cinema italiano postcoloniale, vol. 1 di Cinema e storia, Rubbettino 2024 (con Damiano Garofalo e Luca Carminati), Storia del colonialismo italiano. Politica, cultura e memoria dall’età liberale ai nostri giorni, Carocci 2024 (con Alessandro Pes), Per una nazione coloniale. Il progetto imperiale fascista nei periodici coloniali, Morlacchi 2018, Europa in movimento. Mobilità e migrazioni tra integrazione europea e decolonizzazione, 1945-1992, Il Mulino 2017 (con Giuliana Laschi e Alessandro Pes), La Madrepatria è una terra straniera. Libici, eritrei e somali nell’Italia del dopoguerra, Le Monnier 2017 e la curatela di Sardegna d’oltremare. L’emigrazione coloniale tra esperienza e memoria, Donzelli 2017.
Prigionieri alleati in Italia
Campi di concentramento, storie di vita e crimini di guerra
Incontro con Isabella Insolvibile, autrice di La prigionia alleata in Italia, 1940-1943 (Viella 2023)
giovedì 6 marzo, ore 18
Galleria Europa, Piazza Grande 17, Modena
L'autrice dialoga con Fabio Montella, Istituto storico di Modena
in collaborazione con Fondazione Fossoli, Istituto nazionale Parri di Milano e Monte San Martino Trust
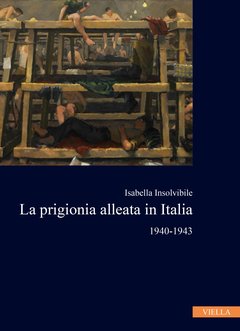 Tra il 1940 e il 1943 circa 70.000 soldati alleati furono prigionieri in Italia. Catturati sui fronti africani, vennero detenuti in quasi tutte le regioni italiane, in campi che rappresentarono uno specifico universo di cattività, indagato qui per la prima volta nella sua interezza. L’Italia della seconda guerra mondiale non fu in grado di rispettare i suoi doveri di potenza detentrice, e la miseria patita dai suoi cittadini ebbe serie conseguenze anche sui prigionieri. In alcuni casi, poi, le autorità dei campi si resero responsabili di veri e propri crimini di guerra nei confronti dei nemici detenuti. La prigionia alleata nel nostro paese, che questo libro ricostruisce, è dunque un altro dei “luoghi” della storia in cui si infrange il mito degli italiani brava gente.
Tra il 1940 e il 1943 circa 70.000 soldati alleati furono prigionieri in Italia. Catturati sui fronti africani, vennero detenuti in quasi tutte le regioni italiane, in campi che rappresentarono uno specifico universo di cattività, indagato qui per la prima volta nella sua interezza. L’Italia della seconda guerra mondiale non fu in grado di rispettare i suoi doveri di potenza detentrice, e la miseria patita dai suoi cittadini ebbe serie conseguenze anche sui prigionieri. In alcuni casi, poi, le autorità dei campi si resero responsabili di veri e propri crimini di guerra nei confronti dei nemici detenuti. La prigionia alleata nel nostro paese, che questo libro ricostruisce, è dunque un altro dei “luoghi” della storia in cui si infrange il mito degli italiani brava gente.
Isabella Insolvibile insegna Storia contemporanea all’Università telematica Mercatorum e collabora con la Fondazione Museo della Shoah. Si occupa di Resistenza, prigionia e crimini di guerra. Tra i suoi libri, ricordiamo: La prigionia alleata in Italia, 1940-1943, Viella 2023; Cefalonia. Il processo, la storia, i documenti, Viella 2017 (con Marco De Paolis); Wops. I prigionieri italiani in Gran Bretagna (1941-46), ESI 2012; Kos 1943-1948. La strage, la storia, ESI 2010.
Storie materiali e “resistenti”
Raccontare la Resistenza con gli oggetti
Incontro con Paola Boccalatte e Mirco Carrattieri, curatori di Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, Biblion 2024
martedì 22 aprile, ore 17.30
Ridotto del Teatro Storchi, largo Garibaldi 15, Modena
Gli autori dialogano con Claudio Silingardi, Istituto storico di Modena
in collaborazione con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale e Comitato per la storia e le memorie del Novecento del Comune di Modena
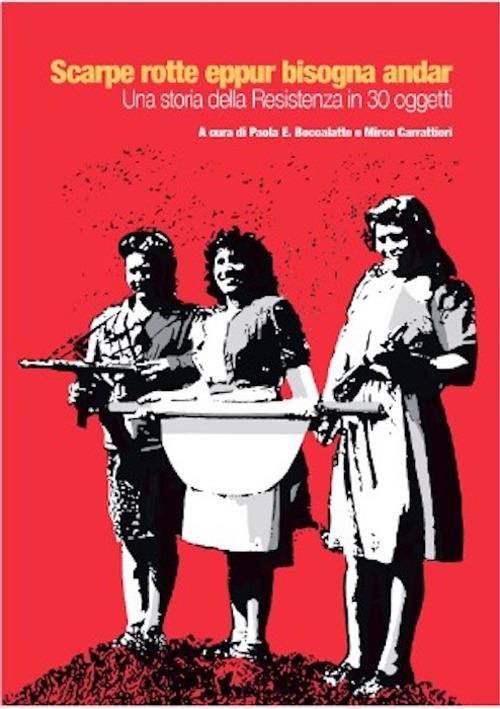 Il “ritorno dell’oggetto” nei musei storici, dopo la sbornia multimediale che aveva portato alla loro virtuale scomparsa, ne esalta il valore evocativo, ma perché questo sostenga un’adeguata conoscenza c’è bisogno dell’intervento dello specialista che riesca a contestualizzarli, come nelle trenta schede qui pubblicate. Si mette così a fuoco la grande varietà e ricchezza di musei, spesso piccoli e gestiti da associazioni private, che, come sottolinea Paola Boccalatte, si configurano come «comunità patrimoniali» e «musei di narrazione». L’approfondimento della cultura materiale della Resistenza ne restituisce, come evidenzia l’altro curatore, Mirco Carrattieri, il carattere plurale: storie di resistenza armata, di deportazione, di resistenza civile, di opposizione politica pagate spesso a caro prezzo, espressioni di «una minoranza ma di massa, legata al passato però capace di guardare al futuro, drammatica e insieme coraggiosa».
Il “ritorno dell’oggetto” nei musei storici, dopo la sbornia multimediale che aveva portato alla loro virtuale scomparsa, ne esalta il valore evocativo, ma perché questo sostenga un’adeguata conoscenza c’è bisogno dell’intervento dello specialista che riesca a contestualizzarli, come nelle trenta schede qui pubblicate. Si mette così a fuoco la grande varietà e ricchezza di musei, spesso piccoli e gestiti da associazioni private, che, come sottolinea Paola Boccalatte, si configurano come «comunità patrimoniali» e «musei di narrazione». L’approfondimento della cultura materiale della Resistenza ne restituisce, come evidenzia l’altro curatore, Mirco Carrattieri, il carattere plurale: storie di resistenza armata, di deportazione, di resistenza civile, di opposizione politica pagate spesso a caro prezzo, espressioni di «una minoranza ma di massa, legata al passato però capace di guardare al futuro, drammatica e insieme coraggiosa».
Mirco Carrattieri collabora con l’Università di Modena e Reggio Emilia. Coordina il Comitato scientifico di Liberation Route Italia. È membro del Comitato scientifico dell’Istituto Cervi e di Istoreco Reggio Emilia, del quale è stato presidente. È stato direttore della rivista «E-Review»; direttore del Museo della Repubblica di Montefiorino e della Resistenza italiana; direttore generale dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri. Si occupa di storia della storiografia, storia della Resistenza e public history. Tra le sue recenti pubblicazioni ricordiamo: Don Minzoni nel centenario della morte, Patron 2024, Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, Biblion 2024 (con Paola Boccalatte), Educare ad una vita laboriosa, liberale ed onesta. Il Patronato pei Figli del Popolo di Modena 1874-1924, Aliberti 2024 (con Francesco Gherardi), Agli albori della democrazia: la Repubblica dell’Ossola, Biblion 2024 (con Luca Zanotta), Partigiani della Wehrmacht. Disertori tedeschi nella Resistenza italiana, Le piccole pagine 2021 (con Iara Meloni), Comunità in guerra sull'Appennino. La Linea Gotica tra storia e politiche della memoria, Viella 2018 (con Alberto Preti), La Resistenza in Italia. Storia, memoria, storiografia, goWare 2016 (con Marcello Flores).
Paola E. Boccalatte, PhD in Storia dell’arte alla Scuola Normale (Pisa), dal 2000 ha collaborato con musei d’arte, archeologia e storia. Come consulente è stata curatrice di MuseoTorino – il museo online della città di Torino – e ha contribuito alla progettazione del Museo della Frontiere del Forte di Bard (Aosta) e al Museo Cervi di Gattatico (Reggio Emilia). Dal 2018 al 2022 ha collaborato con il Museo diffuso della Resistenza (Torino).
Capire la guerra
Continuità e trasformazioni dei conflitti nel passato più recente
Incontro con Marcello Flores, coautore di Perchè la guerra (Laterza 2024)
martedì 6 maggio, ore 18
Galleria Europa, Piazza Grande 17, Modena
L'autore dialoga con Giulia Ricci, Istituto storico di Modena
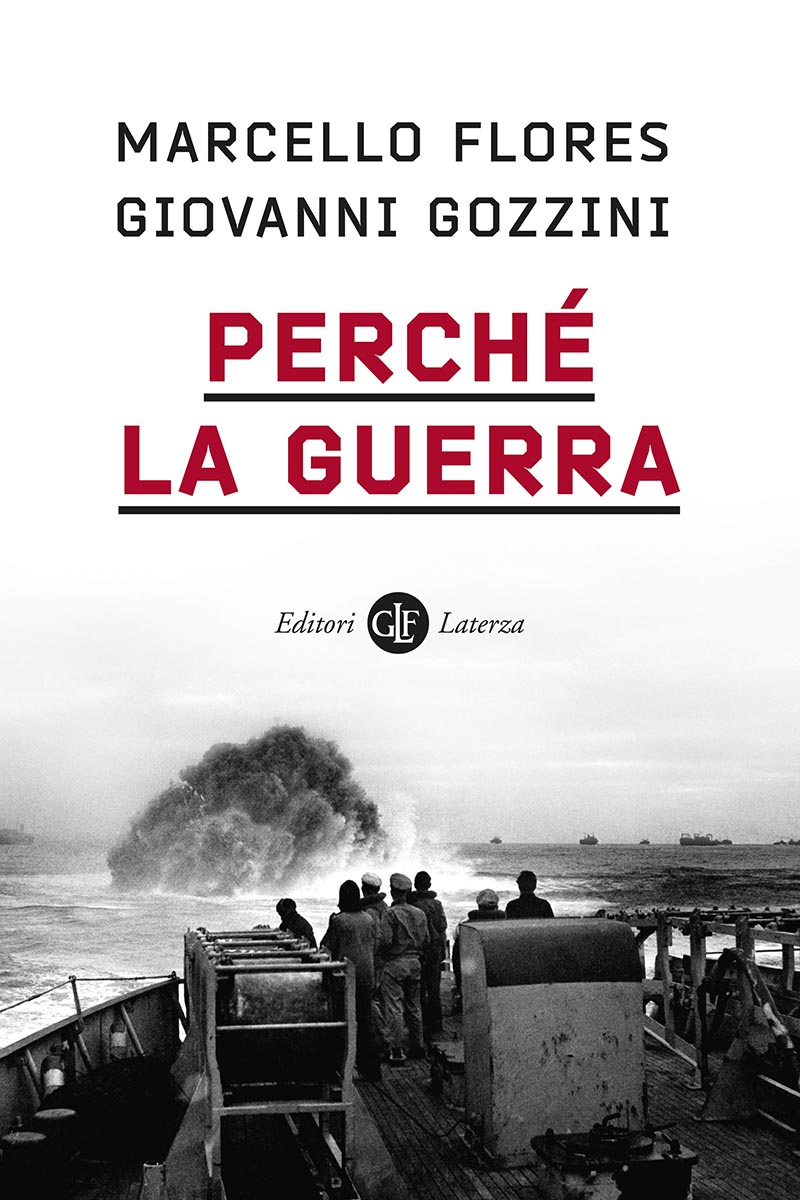 Da sempre gli uomini combattono. Da sempre le guerre segnano la storia. Ma le guerre non sono sempre state la stessa cosa, si sono trasformate e con esse le ragioni per le quali gli uomini combattono. E conoscere la storia ci può aiutare a capire come possiamo fare la pace e renderla duratura.
Da sempre gli uomini combattono. Da sempre le guerre segnano la storia. Ma le guerre non sono sempre state la stessa cosa, si sono trasformate e con esse le ragioni per le quali gli uomini combattono. E conoscere la storia ci può aiutare a capire come possiamo fare la pace e renderla duratura.
La domanda «perché la guerra» è tornata prepotente. Gli storici hanno una risposta semplice: le guerre sono sempre esistite e quindi sempre esisteranno. Ma anche le paci sono sempre esistite e quindi sempre esisteranno. Questo libro cerca una risposta nei fatti: è in aumento il numero di conflitti armati e di vittime di guerra? Sì, in cifra assoluta (ma di poco), no, in rapporto al numero crescente di stati e di abitanti della Terra. Le guerre sono cambiate. È aumentato il numero di attori non statali come Hamas e i separatisti filorussi del Donbass in Ucraina. E le guerre si sono imbastardite: solo raramente sono scontri campali tra eserciti, più spesso si fa uso di missili, droni, attentati contro civili. Per questo ci fanno ancora più paura. Non cambia invece la sostanza: le guerre sono frutto di decisioni politiche di uomini contro altri uomini. Non sono il prodotto ineluttabile di una natura umana malvagia. Siamo capaci di guerra e di pace. Dipende dalle circostanze: c’è stato un periodo di pace sostanziale subito dopo la fine della Guerra Fredda, grazie alle operazioni di peacekeeping condotte dai caschi blu dell’ONU. Potremmo e dovremmo farlo anche oggi.
Questa è la via maestra, forse l’unica, per un pacifismo che non voglia limitarsi alla salvezza farisaica della propria anima.
Marcello Flores ha insegnato Storia contemporanea nelle Università di Trieste e di Siena, dove ha diretto il master europeo in Human Rights and Genocide Studies. Si è occupato di storia dei totalitarismi e di storia dei genocidi. Tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo: Perchè la guerra, Laterza 2024 (con Giovanni Gozzini), Conflitto tra poteri. Magistratura, politica e processi nell’Italia repubblicana, Il Saggiatore 2024 (con Mimmo Franzinelli), Perché il fascismo è nato in Italia, Laterza 2022 (con Giovanni Gozzini), Il mondo contemporaneo 1945-2020, Il Mulino 2021, Il genocidio, Il Mulino 2021, Il vento della rivoluzione. La nascita del Partito comunista italiano, Laterza 2021 (con Giovanni Gozzini), Storia della Resistenza, Laterza 2019 (con Mimmo Franzinelli) e 1968. Un anno spartiacque, Il Mulino 2018 (con Giovanni Gozzini).
Entrare nel mondo degli uomini
Percorsi di donne tra Resistenza e democrazia - APPUNTAMENTO EXTRA
Incontro con Margherita Becchetti, autrice di Non per bellezza. Donne (e uomini) nella lotta partigiana (MUP 2025)
venerdì 30 maggio, ore 18
Galleria Europa, Piazza Grande 17, Modena
L'autrice dialoga con Caterina Liotti, Centro documentazione donna di Modena, e Claudio Silingardi, Istituto storico di Modena
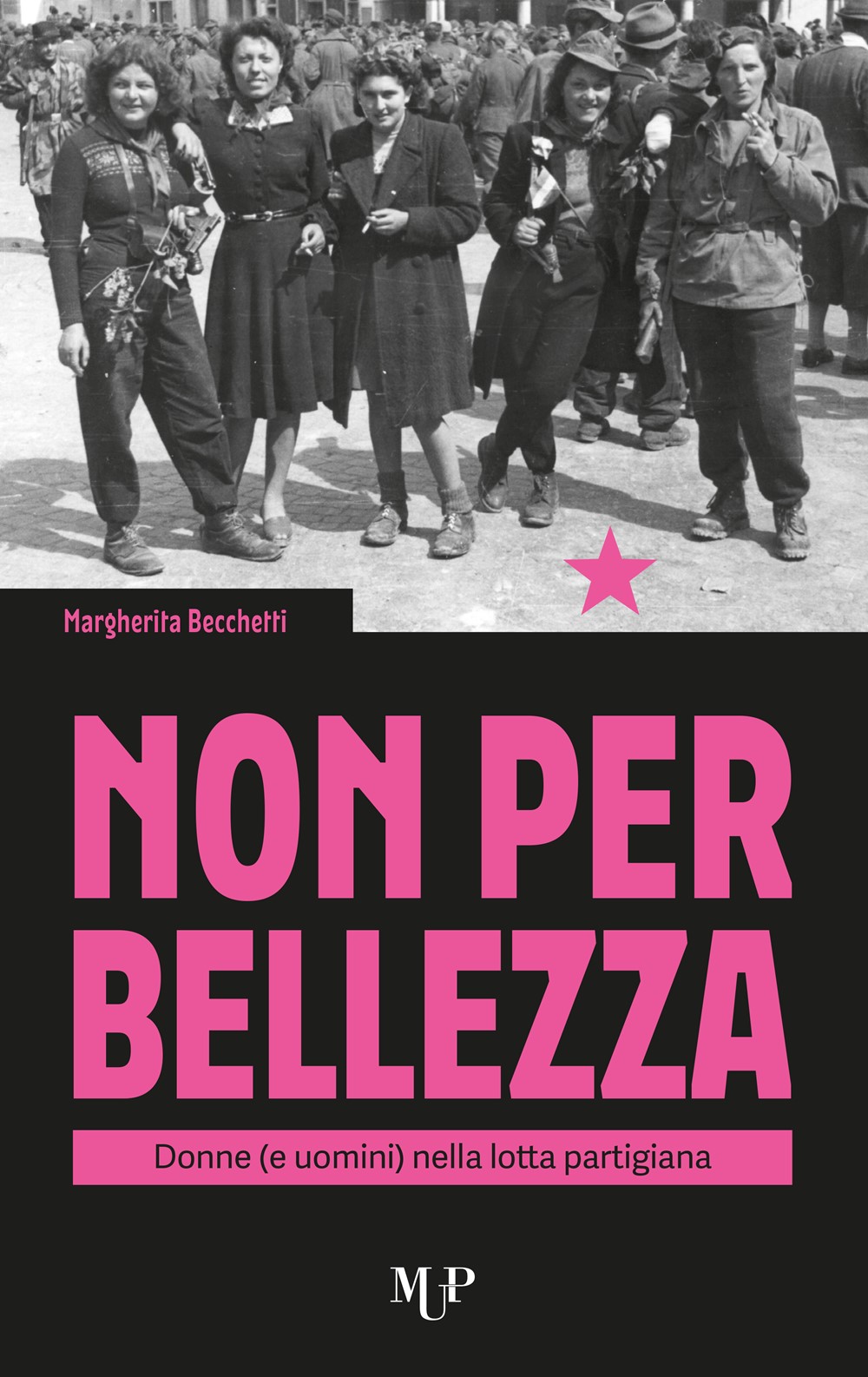 Quando Elsa Oliva è salita in montagna per unirsi a una formazione partigiana ha messo subito le cose in chiaro con gli uomini che le lanciavano sguardi sornioni. Ha detto loro che non era lì per cercarsi un innamorato, né per servirli o curarli. Ha chiesto di avere un’arma, altrimenti se ne sarebbe andata, e ha aggiunto che l’avrebbe tenuta non per bellezza. Elsa Oliva aveva una determinazione rara per le donne di allora. Non tutte hanno saputo essere decise e spavalde come lei. Entrare nel mondo degli uomini è stato difficile; alcune ce l’hanno fatta, altre ne sono rimaste ai margini. Tutte hanno pagato un prezzo.
Quando Elsa Oliva è salita in montagna per unirsi a una formazione partigiana ha messo subito le cose in chiaro con gli uomini che le lanciavano sguardi sornioni. Ha detto loro che non era lì per cercarsi un innamorato, né per servirli o curarli. Ha chiesto di avere un’arma, altrimenti se ne sarebbe andata, e ha aggiunto che l’avrebbe tenuta non per bellezza. Elsa Oliva aveva una determinazione rara per le donne di allora. Non tutte hanno saputo essere decise e spavalde come lei. Entrare nel mondo degli uomini è stato difficile; alcune ce l’hanno fatta, altre ne sono rimaste ai margini. Tutte hanno pagato un prezzo.
E dunque cosa ha significato per loro la lotta partigiana? Come sono state accolte o trattate? E quanto di ciò che hanno vissuto assomiglia a quello che provano le donne del nostro tempo quando si addentrano negli universi maschili?
Margherita Becchetti è dottoressa di ricerca in Storia presso l'Università di Parma e ricercatrice del Centro studi e movimenti. Si è occupata di storia della Resistenza, dell'antifascismo e dei movimenti sociali e politici tra Italia liberale e Italia repubblicana.
Ha pubblicato diverse monografie, tra cui Fuochi oltre il ponte. Rivolte e conflitti sociali a Parma (1868-1915), nuova ed. MUP 2022, e Il teatro del conflitto. La Compagnia del Collettivo nella stagione dei movimenti. 1968-1976, Odradek 2003. È tra gli autori di Una stagione di fuoco. Fascismo guerra Resistenza nel Parmense, BFS 2021, e ha curato, con Paolo Giandebiaggi, il volume I Capannoni a Parma. Storie di persone e di città, MUP 2020.
♦ Tutti gli incontri sono rivolti a studenti, studentesse, insegnanti, studios* e aperti a tutta la cittadinanza.
♦ Per gli insegnanti è possibile richiedere l’attestato di partecipazione.


